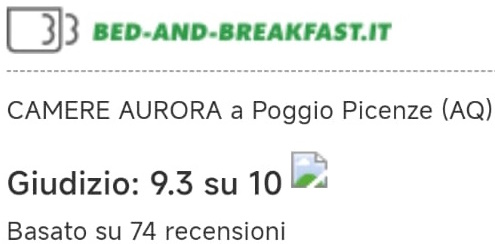REPERTI ARCHEOLOGICI
NECROPOLI DI POGGIO PICENZE (AQ)

La Necropoli di Poggio Picenze: Un Tesoro Intatto dell'Antica Aveia Svela i Segreti dei Vestini
A pochi passi dalla rinomata necropoli di Fossa, nel territorio di Poggio Picenze, un'emozionante scoperta archeologica sta riscrivendo la storia dell'antica città di Aveia: la necropoli di Varranone.
Questo vasto cimitero, che insieme a quello di Fossa apparteneva alla grande città romana, ha restituito oltre 60 tombe di diverse tipologie – a tumulo, a fossa e a camera – databili tra l'VIII e il I secolo a.C.
L'evento più straordinario è stata l'apertura di una tomba a camera del II secolo a.C., un ritrovamento eccezionale perché giunto fino a noi completamente intatto, sigillato per oltre 2100 anni. A differenza delle altre tombe abruzzesi, questa non era stata riempita da terra e detriti nel corso dei millenni, un caso rarissimo che ha suscitato grande emozione tra gli archeologi.
Immagina il momento in cui la pesante lastra di pietra bianca, custode di questo sonno millenario, è stata delicatamente sollevata. Per la prima volta dopo secoli, il sole ha illuminato l'interno della camera funeraria, r

ivelando le fragili ossa di una donna, probabilmente una fanciulla, come suggerisce il ritrovamento di un piccolo portaprofumi tra gli oggetti del corredo.
Oltre al profumatore, sono emerse ampolline porta profumo, brocche, pedine da gioco e una bella lucerna, i primi indizi di un ricco corredo funerario che sarà studiato minuziosamente dagli archeologi.
La struttura della tomba, con il suo soffitto a botte e la forma a "L" molto tozza, presenta architrave e pareti perfettamente conservati, con intonaco ancora integro e lastre levigate.
La posizione della tomba, lungo un'antica strada basolata che conduceva alla necropoli – un vero e proprio "viale del cimitero" – suggerisce l'importanza della defunta all'interno della comunità vestina. Come spiega l'archeologo Vincenzo D'Ercole, le tombe dei personaggi più importanti venivano spesso collocate in prossimità delle vie principali.
Perché questa scoperta è così importante?
- Una tomba intatta dopo 2100 anni: Un evento rarissimo che offre uno sguardo unico sui rituali funerari dell'epoca.
- Un ricco corredo femminile del popolo dei Vestini: Gli oggetti ritrovati forniscono preziose informazioni sulla vita, le usanze e lo status sociale delle donne di questa antica popolazione abruzzese.
- Un ulteriore tassello nella storia di Aveia: La necropoli di Varranone, insieme a quella di Fossa, contribuisce a ricostruire la storia e la cultura di questa importante città romana
- La conferma dell'importanza delle necropoli per i Vestini: La scelta di dedicare aree pianeggianti alle sepolture, anziché all'agricoltura, testimonia la loro considerazione per i luoghi di riposo eterno.
- Un'opportunità per la ricerca e la valorizzazione della "Via dei Vestini": Questa scoperta auspica una maggiore attenzione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la ricostruzione della storia di questo affascinante popolo.
Visitare Poggio Picenze e la necropoli di Varranone significa immergersi in un passato millenario, toccare con mano la storia di un popolo fiero e scoprire i segreti custoditi gelosamente per oltre due millenni. Un'esperienza archeologica ed emotiva di grande impatto, un'occasione unica per connettersi con le radici più profonde dell'Abruzzo.
NECROPOLI DI FOSSA (AQ)
I letti funerari in osso della necropoli di Fossa (AQ)
Giorni e orario apertura:
Da Giugno ad Ottobre: nei giorni di sabato e domenica (mattina ore 10:00 - 13, pomeriggio ore 15:30 - 18:30). agosto la Necropoli è aperta anche dal lunedì al venerdì (pomeriggio ore 16:30 - 19:30).; Prenotazione: Nessuna
Sito web:

Fossa e i Letti Funerari in Osso: Un Viaggio nel Lusso e nei Riti Funerari dell'Antica Aveia
A Fossa, sulle cui fondamenta riposa l'antica città vestina e poi romana di Aveia, è emerso un tesoro archeologico di straordinaria importanza: i letti funerari in osso. Questa scoperta, definita tra le più significative degli ultimi dieci anni, apre una finestra affascinante sui costumi funerari, il lusso e le dinamiche sociali dell'Abruzzo in epoca ellenistico-romana.
Perché questi letti funerari sono così speciali? Negli ultimi vent'anni, numerosi studiosi si sono dedicati alla loro analisi tipologica, iconografica e ricostruttiva, gettando le basi per una comprensione scientifica di questi manufatti unici.
L'attenzione si è concentrata sulle tecniche di realizzazione, sui centri di produzione, sulle botteghe artigiane e, attraverso le fonti letterarie e i reperti stessi, sulla ricerca dei modelli che li hanno ispirati e sulla simbologia funeraria racchiusa nelle loro decorazioni.
La necropoli di Fossa, con il ritrovamento di questi preziosi oggetti, offre un'opportunità imperdibile per approfondire l'aspetto antroposociologico del rito funerario, studiando attentamente i contesti di rinvenimento dei letti e il loro significato a livello locale.
Sebbene le prime notizie sui ritrovamenti risalgano alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, spesso con descrizioni sommarie, è grazie a studi più recenti, come quello pionieristico di C. Letta e il lavoro di Chiara Bianchi sui letti di Cremona, che si è affinata la nostra capacità di classificazione e di comprensione dei centri di produzione.
Il confronto tra i letti di Fossa e quelli della vicina necropoli di Bazzano rivela un quadro complesso e stimolante dell'Abruzzo in età ellenistico-romana. Questa scoperta non solo arricchisce la nostra conoscenza dei costumi funerari dell'epoca e dei significati religiosi e sociali legati all'uso di questi letti, ma testimonia anche la presenza di oggetti di lusso di elevato tenore nell'area aquilana in epoca romana.
La raffinatezza di questi manufatti è un documento significativo del livello di artigianato e dei beni che circolavano nella regione, permettendoci di comprendere meglio i rapporti e le influenze delle più grandi e ricche città del centro Italia con cui l'area aquilana era in contatto.
Perché visitare Fossa e scoprire i suoi letti funerari?
- Un ritrovamento archeologico eccezionale: Ammira reperti unici che illuminano i riti funerari di un'epoca passata.
- Un'immersione nel lusso dell'antichità: Scopri oggetti di pregio che testimoniano l'alto tenore di vita dell'area in epoca romana.
- Un'opportunità per comprendere le dinamiche sociali e culturali: Attraverso lo studio dei contesti di rinvenimento, potrai farti un'idea delle credenze e delle usanze funerarie dell'epoca.
- Un tassello importante per la storia dell'Abruzzo: La scoperta integra le nostre conoscenze sul territorio in età ellenistico-romana e sui suoi legami con il resto della penisola.
- Un'occasione per riflettere sul significato della morte e del ricordo: I letti funerari erano oggetti carichi di simbolismo e di valore affettivo per le comunità antiche.
Visitare Fossa significa intraprendere un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta di un passato ricco di storia e di testimonianze preziose, dove il lusso si intrecciava con i riti sacri della sepoltura. Un'esperienza culturale di grande impatto emotivo e intellettuale.
AMITERNUM e le catacombe DI SAN VITTORINO - L'Aquila

Amiternum: Un'Emozionante Immersione nell'Antica Sabina e Romana
Lungo la strada che dolcemente conduce da L'Aquila verso Amatrice, preparati a un incontro straordinario con la storia: le imponenti vestigia di Amiternum, un'antica e fiorente città sabina che conobbe anche la grandezza di Roma. Questo sito archeologico, ricco di fascino e di testimonianze millenarie, ti aspetta per un'indimenticabile esplorazione.
Il teatro romano, incastonato con maestria nel fianco di una collina, ti sorprenderà per la sua acustica ancora oggi perfetta. Risalente all'epoca augustea, evoca le rappresentazioni che un tempo animavano questo luogo. Poco distante, l'imponente anfiteatro, datato al I secolo d.C., conserva gran parte del suo perimetro, permettendoti di immaginare le antiche competizioni e la vivace folla che lo riempiva.
Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce i resti di una raffinata struttura tardo romana, con ambienti decorati da splendidi mosaici dai colori vivaci e affreschi che narrano storie lontane. Nel cuore del vicino borgo di San Vittorino, la suggestiva chiesa romanica custodisce un tesoro nascosto: le catacombe dedicate a San Vittorino, un antico cimitero sotterraneo che si sviluppò attorno alla tomba del Santo nel V secolo, un luogo intriso di spiritualità e storia paleocristiana.
Non perdere l'opportunità di visitare Amiternum perché:
- È un sito archeologico di primaria importanza per comprendere la storia dei Sabini e la romanizzazione del territorio.
- Potrai ammirare un teatro romano con un'acustica così eccezionale da farti rivivere gli spettacoli di un tempo.
- L'imponente anfiteatro ti trasporterà nell'atmosfera delle antiche competizioni gladiatoriali.
- I resti delle domus romane con i loro mosaici e affreschi ti offriranno uno spaccato della vita quotidiana e del lusso dell'epoca.
- Le catacombe di San Vittorino rappresentano una preziosa testimonianza delle prime comunità cristiane e della loro fede.
- La sua facile accessibilità dalla strada statale 80 la rende una tappa culturale ideale durante il tuo itinerario alla scoperta dell'Abruzzo.
Amiternum è un invito a un viaggio emozionante nel cuore della storia, un'occasione unica per connetterti con le radici antiche di questa terra e lasciarti affascinare dalla grandezza del suo passato.

Peltuinum: Un Viaggio Emozionante tra Vestigia Romane e Paesaggi Abruzzesi
Immergiti in un'atmosfera sospesa nel tempo a Peltuinum, un sito archeologico di eccezionale valore storico e paesaggistico, incastonato nella suggestiva vallata di Popoli.
Questa antica città, cuore pulsante del popolo vestino e fiorente municipio romano, sorge in una posizione strategica tra le imponenti vette del Gran Sasso e del Sirente-Velino, offrendo uno scenario naturale di rara bellezza.
Passeggiando tra le rovine di Peltuinum, potrai ammirare la grandiosità del complesso teatro-tempio, un'imponente testimonianza dell'architettura pubblica romana di età augustea, dove un tempo si svolgevano spettacoli e cerimonie religiose.
Lasciati condurre dall'immaginazione tra i resti delle poderose mura di cinta, che un tempo definivano il perimetro della città e ne sottolineavano l'importanza strategica nel controllo del territorio.
Segui le tracce del Regio Tratturo Borbonico, l'antica via della transumanza che attraversava il pianoro, evocando immagini di pastori e greggi che per secoli hanno solcato queste terre. Osserva con attenzione come le antiche vestigia di Peltuinum siano state riutilizzate nel corso dei secoli, con blocchi di pietra romana che hanno trovato nuova dimora nelle chiese medievali e nei castelli circostanti, creando un affascinante dialogo tra epoche diverse.
La posizione di Peltuinum è un vero invito all'esplorazione: circondata dalla maestosità delle montagne abruzzesi e a breve distanza dai rinomati Parchi Nazionali, offre l'opportunità unica di combinare la scoperta di un importante sito archeologico con indimenticabili escursioni nella natura incontaminata.
Vieni a Peltuinum per:
- Rivivere la storia millenaria di un importante centro vestino e romano.
- Esplorare un complesso monumentale unico, con un teatro e un tempio che narrano storie di un passato glorioso.
- Immergerti in un paesaggio naturale di incomparabile bellezza, tra montagne imponenti e valli serene.
- Scoprire le tracce di antiche vie di comunicazione come il tratturo.
- Apprezzare il legame tra il mondo antico e il Medioevo attraverso il riutilizzo dei materiali edilizi.
- Godere della facile accessibilità del sito, ideale per una gita culturale e naturalistica.
Peltuinum ti aspetta per svelarti i suoi segreti, offrendoti un'esperienza ricca di storia, cultura e natura nel cuore autentico dell'Abruzzo. Un viaggio indimenticabile alla scoperta delle radici di questa terra.
CORFINIUM –SULMONA (AQ)

Corfinium: Alle Origini dell'Italia, Tra Vestigia Romane e la Basilica di San Pelino
Immagina di trovarti nella conca di Sulmona, un luogo che fu crocevia di antiche civiltà. Qui sorgeva Corfinium, strategicamente posizionata sulla Via Valeria. L'attuale borgo medievale si adagia sullo stesso sperone roccioso, invitandoti a ripercorrere secoli di storia.
Passeggiando per Piazza Corfinio, noterai come le case seguano la curva dell'antico teatro romano, un'eco silenziosa del passato. Poco distante, la maestosa basilica Valvense di San Pelino ti accoglie con la sua architettura romanica, custode delle spoglie del Santo martire e di preziosi tesori artistici come l'ambone del XII secolo e affreschi trecenteschi.
Ma Corfinium vanta un primato unico: fu la prima capitale d'Italia nel 90 a.C., quando i popoli italici confederati si ribellarono a Roma. Sebbene la sua "capitolinità" durò solo un anno, il suo significato storico èimmortale.
Le rovine dell'antica città, pur non essendo imponenti, evocano ancora la sua importanza strategica e il suo ruolo cruciale nella storia.
Perché una visita a Corfinium è imperdibile?
- Scopri il luogo che fu la prima capitale d'Italia.
- Ammira la splendida basilica di San Pelino, un gioiello romanico ricco di storia e arte.
- Esplora le vestigia dell'antica Corfinium, immaginando il suo passato glorioso.
- Ripercorri le vicende della Guerra Sociale, un momento chiave della storia romana e italica.
- Immergiti nella bellezza della conca di Sulmona.
- Facilmente raggiungibile lungo un'importante strada.
Corfinium ti aspetta per un viaggio emozionante alle radici della nostra storia, tra testimonianze romane e un'antica basilica di grande fascino. Un'occasione unica per connetterti con il passato dell'Abruzzo e dell'Italia.
Notizie tratte in rete